Malattie della vite - Archivio domande/risposte
 Torana alla sezione principale
Torana alla sezione principale
Acinellatura
Appassimento e rinsecchimento nel giro di pochi giorni
Ascomicete, che vuol dire ?
Barbatelle infette ? Virus GLFV
Botrite : momenti importanti per la difesa della vite
Botrite : problemi in fase di vinificazione di uve passite
Botrite : quale il miglior principio attivo ?
Byctiscus betulae (Foglie accartocciate a sigaro)
Cicalina Bufalo
Enazioni...queste sconosciute
Erinosi da acaro eriofide "Colomerus Vitis"
Erinosi e acari eriofidi...ancora "Colomerus Vitis"
Escoriosi della vite, quali i rimedi ?
Escoriosi su Red Globe trattabile con Mancozeb ?
Eutypa Lata ed Eutipiosi
Flavescenza dorata, trattamenti insetticidi e mal dell'esca
Flavescenza dorata in Emilia Romagna
Flavescenza dorata su vite americana
Flavescenza dorata e sintomi premonitori
Marciume Nero e macchie circolari marroni
Melata nera...cocciniglie ?
Oidio e Pinot Grigio
Oidio e Ampelomyces quisqualis
Oidio, trattamenti specifici
Oidio, sintomi e trattamenti specifici
Peronospora e palline da cimici
Tignoletta e trattamenti con Bacillus
Acinellatura
Mi permetto di porre un quesito al quale Lei sicuramente saprà dare
una risposta e nel contempo La ringrazio:
"quale potrebbe essere la causa per cui molti acini di un grappolo
(anche di varietà diverse) non raggiungono la maturazione, ma
rimangono piccoli ed acerbi, arrecando un grave danno, poiché se
vendemmiati contribuiscono a peggiorare la qualità"?
Le cause dell' "acinellatura" (=presenza sullo stesso grappolo di bacche
normalmente sviluppate ed altre non ingrossate, verdi ed apirene) possono
essere diverse:
- mancata fecondazione di tutti i fiori del grappolo; gli ovari non impollinati
rimangono piccoli (eccessivo carico d'uva? freddo e pioggia in epoca di
fioritura?).
- carenza di Boro.
- cause patologiche. In modo particolare due virosi della vite determinano, tra
gli altri sintomi, l'acinellatura: l'Accartocciamento Fogliare e il Mosaico
Giallo (o Arricciamento Fogliare).
Conseguenze dell'acinellatura sono peggioramento quantitativo (diminuzione peso
del grappolo) e qualitativo (minor contenuto in zuccheri nella bacca).
Appassimento e rinsecchimento nel giro di pochi giorni
Ho un vigneto di circa 400 piante e dall'anno scorso,alcune viti
improvvisamente, a volte quando l'uva era presso che matura, si sono appassite
e nel giro di pochi giorni si sono rinsecchite.
Quest'anno il fenomeno si sta ripetendo.
Nessuno è in grado di consigliarmi un medoto di lotta.
Le sarei grato se mi potesse dare alcune indicazioni atte per combattere la malattia
ed evitare che per l'avvenire si ripeta.
La ringrazio e distintamente La saluto.
Luciano Chiarini
Le cause del rinsecchimento del grappolo potrebbero essere diverse.
La malattia (se di malattia si tratta), descritta così, mi risulta un po' difficile
da individuare.
Potrebbe essere flavescenza dorata, anche se il grappolino di solito rinsecchisce
all'inizio del suo sviluppo, non in prossimità della maturazione.
Oppure potrebbe essere peronospora, o qualche altro fungo patogeno.
Sul resto della pianta (foglie, germogli, tralci) non ha notato altre manifestazioni
particolari o alterazioni di vario genere?
Mi dispiace non poterle fare una diagnosi precisa, ma se vuole mandarmi una
descrizione più dettagliata e precisa (se può alleghi una fotografia alla mail),
potrebbe essere utile per cercare di capire cosa sta succedendo alle sue viti.
Cordiali saluti, e a presto.
Ascomicete, che vuol dire ?
Sono una studentessa di Lingue dell'Università di Genova,e sto effettuando
delle ricerche su alcuni termini per la preparazione della tesi.
Uno di questi termini è ascomicete,ho già effettuato alcune ricerche ma non sono
riuscita a trovarne la definizione e dei sinonimi(se esistono).
La pregherei di inviarmi una mail con tutte le informazioni che sono in suo
possesso,se le è possibile.
Ringraziandola anticipatamente per la sua cortesia, cordiali saluti,
Silvia Conca
Gli ascomiceti (Ascomycetes) rappresentano una delle numerose classi in cui è
suddiviso il regno dei funghi, anche detti "miceti" (Mycetes).
Nella classificazione generale dei funghi, gli ascomiceti fanno parte della divisione
Eumycota, e sottodivisione Ascomycotina. A loro volta, gli ascomiceti comprendono
diversi ordini, famiglie e generi minori.
Quindi, riassumendo:
regno: Fungi,
divisione: Eumycota,
sottodivisione: Ascomycotina,
classe: Ascomycetes,
ordine: ...
famiglia: ...
genere: ...
Il nome deriva dal greco, dove "ascos" significa sacco. Infatti questi funghi sono
caratterizzati dall'avere delle particolari strutture sacciformi (gli aschi appunto)
all'interno delle quali portano le spore sessuali, dette "ascospore".
Che io sappia non ci sono sinonimi.
Erinosi da acaro eriofide "Colomerus Vitis"
Gentile dott.ssa Zorloni,
gradirei sapere che tipo di malattia ha attaccato la vite di mio nonno,
site nella zona di Montemarano (AV) una contrada distante dal centro abitato.
Mi è difficile spiegare la sua manifestazione, quindi in allegato
Le invio delle foto della parte superiore ed inferiore delle foglie malate.
L'uva è ancora sana, l'anomalia per ora è presente solo sulle foglie.
La ringrazio anticipatamente e buona giornata!
Innanzitutto complimenti per le foto che mi ha inviato, sono chiarissime,
oserei dire da manuale.
Si riferiscono, senza ombra di dubbio, ai danni provocati dall'acaro eriofide
Colomerus vitis, agente della malattia denominata "erinosi".
Si tratta di una malattia abbastanza diffusa, ma solitamente poco dannosa,
quindi poco combattuta.
Nella maggior parte dei casi, infatti, essa colpisce solamente le foglie, con i
sintomi raffigurati nelle foto che mi ha mandato.
Solo nei casi più gravi, Colomerus vitis colpisce anche i germogli ed i grappolini,
provocando ritardi vegetativi e limitazione della produzione.
In questi casi sarà allora opportuno intervenire, preferibilmente all'inizio della stagione
vegetativa, con un prodotto acaricida.
Erinosi e acari eriofidi...ancora su "Colomerus Vitis"
Gent.ma dott.ssa Zorloni,
Sono un neo-viticoltore. Ho da poco impiantato delle viti di "refosco" che
ho curato come le viti di "malvasia" già presenti nel mio orto con
trattamenti rameici e zolfo.
Purtroppo sulla parte superiore delle foglie di alcune piante di "refosco
(e soltanto su queste e non sulle viti di malvasia) sono comparse delle
bolle irregolari mentre sulla parte inferiore, in corrispondeza dei
rigonfiamenti è presente una patina grigia.
Malgrado le bolle, tutte le foglie colpite sono perfettamente verdi.
Un paio di piante presentano il problema su quasi la totalità delle foglie
mentre altre soltanto su una decina di foglie.
Ho cercato di individuare la malattia osservando le foto presenti tra
le "malattie inserite" ma non mi sono state di aiuto.
Le saro grato se potesse darmi qualche indicazione sul problema,
la sua gravità. La ringrazio
Sicuramente si tratta di un attacco di acari eriofidi, per la precisione di
Colomerus vitis, agente della cosiddetta "erinosi".
Il sintomo caratteristico è proprio quello che mi ha descritto lei, cioè la presenza
di estroflessioni bollose sulla pagina superiore della foglia (che rimane di colore
verde), alle quali corrispondono, sulla pagina inferiore, delle zone introflesse
con aspetto feltroso, dovuto alla presenza di peli biancastri.
La presenza dei sintomi solo su determinate varietà può dipendere dalla differente
sensibilità varietale nei confronti dell'acaro, oltre che ad una diversa "preferenza"
di quest'ultimo per una varietà piuttosto che per un'altra.
I danni comunque non sono quasi mai preoccupanti, a meno che non si tratti di
attacchi eccessivi che si estendono anche ai grappoli.
Solo in quest'ultimo caso può essere utile intervenire con prodotti chimici
(ad esempio con bromopropilato).
Spero di esserle stata d'aiuto.
Escoriosi della vite
Quali metodi di potatura e fitofarmaci si devono usare
per combattere l' escoriosi della vite ?
Quali sono i fitofarmaci più efficaci in commercio ?
Quali sono i periodi più appropriati per combattere la malattia
con i fitofarmaci?
Coltivo uva da tavola della varietà precoce "VICTORIA" su un
terreno nero di impasto argilloso.
In vigneti infetti da escoriosi la potatura assume importanza particolare in
quanto deve essere effettuata con molta cautela al fine di non diffondere
ulteriormente il fungo patogeno alle piante sane.
Si consiglia di potare i tralci malati ed eliminarli con il fuoco, così da
distruggere il patogeno. Inoltre sarebbe opportuno potare le piante malate
distintamente da quelle sane, magari dare la precedenza a quelle sane e poi
passare a quelle malate ed utilizzare cesoie diverse. Questi accorgimenti
sono utili sempre al fine di non trasmettere il patogeno alle piante sane.
Per quanto riguarda la lotta chimica, vengono utilizzati prodotti a base di
zolfo bagnabile, ditiocarbammati (mancozeb, methiram), folpet,
diclofluanide, dithianon.
Sono raccomandati due trattamenti distanziati di 8-10 giorni, da effettuare
in primavera alla comparsa dei primi germogli, prima dei trattamenti
antiperonosporici. Meglio effettuare i trattamenti prima delle piogge, che
inducono la sporulazione del fungo. Normalmente, comunque, gli stessi
principi attivi utilizzati contro oidio e peronospora sono efficaci anche
per combattere l'escoriosi.
Escoriosi su Red Globe trattabile con Mancozeb ?
L'escoriosi su Red Globe è trattabile efficacemente con mancozeb?
Ci sono pareri discordanti tra i diversi dottori agrari interpellati.
Qual'è la vostra opinione?
Grazie della gentile risposta.
L'utilizzo di Mancozeb viene consigliato da molti nella lotta all'escoriosi, e viene
indicato anche nei principali testi di patologia vegetale.
Quindi non mi sento di negarne l'efficacia.
L'intervento viene di solito effettuato alla comparsa degli abbozzi fogliari, e ripetuto
dopo una decina di giorni. Sottolineo comunque l'importanza, nella lotta a questa
malattia fungina, delle pratiche preventive quali l'utilizzo di materiale di propagazione
sano, l'eliminazione delle piante infette, ...
Flavescenza dorata, trattamenti insetticidi e mal dell'esca
Sono Andrea Costa tecnico di una piccola realtà produttiva in
Valle d'Aosta. Le pongo una serie di domande sulla "malattia" del
momento la FD. In Vd'A c'è la presenza del vettore ma non vi sono
piante sintomatiche. Secondo il suo parere ha senso consigliare
trattamenti insetticidi in zone dove oramai sono più di 10 che non
si fa uso di tali sostanze ? Oppure, come a noi sembra più logico,
intervenire agronimicamente per far si che la pianta sia in equilibrio
(produzione, concimazioni, potature) e quindi più resistente ad
infezioni varie ?
Lei considera la FD una malattia oppure uno stato di sfruttamento /
deperimento della pianta?
Ritiene la FD più dannosa del Mal dell'Esca ?
Gentile Andrea Costa, cercherò di rispondere in maniera esaudiente alle
domande che mi ha posto.
Per quanto riguarda la Flavescenza dorata, l'assenza di piante sintomatiche
in questo periodo potrebbe essere una cosa abbastanza normale, dal momento
che i sintomi di questa malattia si manifestano maggiormente in estate
avanzata; agosto e settembre sono i mesi in cui i sintomi si vedono meglio,
in modo chiaro ed evidente. Già ora dovrebbero vedersi, ma in maniera
ancora lieve. Dipende molto anche dalla varietà, ci sono varietà più o meno
sensibili, che manifestano in maniera più evidente di altre, e viceversa.
La Flavescenza dorata è una malattia della vite, che può assumere la
gravità di una vera e propria epidemia! Basta una sola pianta infetta, anche in
vigneti vicini, perchè il fitoplasma venga diffuso alle altre piante.
Proprio per questo motivo la presenza della cicalina vettrice, lo
Scaphoideus titanus, rappresenta un pericolo; nutrendosi sulla pianta
malata essa assume il fitoplasma e lo trasferisce su quelle sane, sempre tramite
l'apparato boccale. Proprio per questo motivo le consiglio vivamente di
effettuare i trattamenti insetticidi, che in Lombardia sono obbligatori
(decreto ministeriale del 31 maggio 2000).
L'assenza di sintomi ora non mi dà la certezza assoluta che non ci siano
piante infette.
Anche il Mal dell'Esca è una malattia molto diffusa nei vigneti, e molto
temuta, perchè poco facilmente controllabile. A differenza della Fd, il cui
agente patogeno è un fitoplasma, il mal dell'esca è dovuto all'azione
associata di più patogeni fungini. Tutte e due sono malattie molto dannose
ed in grado di decimare interi vigneti, credo però che oggi come oggi la
diffusione della Fd sia più veloce e meno controllabile, soprattutto perchè
legata ad un insetto in grado di muoversi e riprodursi con grande facilità
(questo sottolinea l'importanza dei trattamenti insetticidi).
Oggi non esistono prodotti chimici in grado di curare specificatamente il
mal dell'esca, e l'unica via di difesa è la prevenzione. Importantissimo è
individuare le piante malate ed eliminarle bruciandone i residui, ed
evitare il contatto con quelle sane in modo da non infettarle.
Anche per la Fd è importante eliminare le piante malate, poichè
costituiscono la fonte di fitoplasma alla quale attinge la cicalina vettrice.
Comunque metterò presto on line su Tigulliovino anche la scheda del mal
dell'esca...spero di esserle stata d'aiuto.
Botrite - Problemi in fase di vinificazione di uve passite
Salve, sono un neo viticoltore alle prime esperienze e come primo anno di
esperienza pratica di vinificazione mi sono avventurato nella tecnica
dell'appassimento delle uve corvina e rondinella al fine di ottenere il vino
"AMARONE", ma ora (27.10.01) la mia uva si trova infestata da botrite,
anche se al momento del raccolto sembrava molto pulita.
Come è potuto succedere questo incidente?
Grazie per la risposta e distinti saluti.
Questa domanda esula abbastanza dal mio campo.
Non conosco bene le tecniche di vinificazione.
Per quel poco che so, e da quello che posso intuire, quando si procede
nell'appassimento dell'uva bisogna controllarla continuamente; è
necessario eliminare tempestivamente gli acini sui quali si manifestano
muffe, o che si presentano lesionati (quindi facilmente attaccabili da
funghi e muffe). Per evitare questi inconvenienti è poi molto importante
mantenere controllato l'ambiente in cui si procede all'appassimento; non
deve esserci umidità, l'ambiente deve essere aerato ed asciutto, la
temperatura deve essere mantenuta a determinati valori.
Sempre per una questione di aerazione credo sia conveniente mantenere i
grappoli distanziati tra di loro, non ammassati.
Bisogna essere particolarmente attenti e precisi, ed avere molta pazienza.
Botrite - Momenti importanti per la difesa della vite
Quali sono i momenti importanti per una migliore difesa botrite
della vite? Ho sentito parlare delle fasi fenologiche A, B, C, D, E,
cosa si intendono?
Sicuri di un Vs. riscontro porgo distinti saluti
Quando si parla di fasi fenologiche A, B, C, D si intendono i momenti in
cui la pianta è maggiormente suscettibile alla malattia.
Esse corrispondono a:
- A: fine fioritura.
- B: imminente chiusura del grappolo.
- C: invaiatura.
- D: 3-4 settimane precedenti la vendemmia.
Quando si programma la lotta (preventiva meglio che curativa) alla botrite,
è bene tenere a dovuta considerazione queste fasi. Solitamente si considera
più che mai necessario intervenire durante la fase D.
La botrite attacca soprattutto gli organi ricchi d'acqua, quindi
soprattutto gli acini.
Bisogna poi considerare la cosiddetta "regola dei due 15": la botrite per
germinare necessita 15°C di temperatura (optimum) ed almeno 15 ore di
bagnatura. Piogge prolungate ed elevata umidità relativa favoriscono lo
sviluppo di questo fungo patogeno.
Spero di esserle stata d'aiuto.
Grazie e distinti saluti.
Botrite - Il miglior principio attivo
Qual'è il migliore principio attivo contro la botrite o muffa grigia
della vite?
I pricipi attivi maggiormente utilizzati nella lotta alla muffa grigia o botrite della vite
sono quelli che ho elencato nella scheda relativa alla malattia, pubblicata sul sito.
Tutti quanti sono molto efficaci se utilizzati nel periodo giusto e nelle dosi consigliate
per ogni prodotto.
Bisogna avere cura di distribuire bene il prodotto in maniera da bagnare tutti i
grappoli.
Byctiscus betulae (Foglie accartocciate a sigaro)
Salve, io e mio padre da circa 10 anni abbiamo con buoni risultati una vigna di
circa 1000 piante. All'inizio era una disastro, abbandonata per anni, era una giungla,
ed era infestata da tutte le malattie. Adesso dopo 10 anni di cure è splendida.
L'unica cosa che non riusciamoa capire è perchè in questo periodo ci sono alcune
foglie accartocciate e secche a foglia di sigaro, come se un insetto ci avesse
fatto il nido. Grazie per la risposta. Marco
Le foglie arrotolate a forma di sigaro, visibili in questo periodo (maggio-giugno) sulle
viti, sono dovute all'attività di un piccolo coleottero, il Byctiscus betulae, che viene
comunemente chiamato "sigaraio" della vite.
All'interno della foglia arrotolata la femmina depone le uova, che schiuderanno
rilasciando le giovani larve.
Questo coleottero non crea danni rilevanti al vigneto, e la sua presenza viene
generalmente trascurata.
Volendo comunque eliminarlo, è sufficiente asportare e distruggere i sigari (e di
conseguenza le uova in esso contenute).
Flavescenza Dorata in Emilia Romagna
Salve sono un agricoltore viticoltore della provincia di Parma,
vorrei avere delucidazioni in merito alla FD.
Il mio vigneto alla fine di giungo ha manifestato sintomi di
ingiallimento fogliare e disseccamento di buona parte dei grappoli
di forte intensità, premetto che il vigneto era regolarmente trattato
con dei rameici, ad oggi la vegetazione è ripresa e solo una pianta
ha sintomi di arrossamento fogliare come da lei descritto, vorrei
sapere se anche l'ingiallimento e dovuto dalla FD
Le uve sono di Lambrusco SALAMINO - SORBARA E FORTANA
Grazie
Gentile sig. Bandini Danilo,
solitamente la FD determina ingiallimento fogliare su varietà bianche ed
arrossamenti su quelle nere. Le foglie di piante colpite da FD, oltre a
variare di colore in maniera più o meno evidente, si accartocciano verso il
basso ed assumono consistenza quasi cartacea. Il disseccamento totale dei
grappolini è un altro sintomo evidente della malattia, il primo a
comparire, e di solito non lascia dubbi. Le consiglio di osservare il portamento della
pianta intera; dal momento che i tralci delle viti infette non lignificano
ma rimangono "gommosi", la pianta assume un aspetto cadente. Gli stessi
tralci inoltre presentano (ma non sempre) delle pustole nere.
In questa stagione ormai i sintomi sono ben evidenti.
Gli ingiallimenti che ha visto a giugno, su varietà nera, e che ora dice non
esserci più, dubito possano essere dovuti a FD.
I prodotti rameici non sono efficaci nella lotta alla FD.
Spero di esserle stata d'aiuto.
Anna Zorloni.
Flavescenza dorata du vite americana
Buonasera. Io posseggo una vite americana che presenta la maggior
parte dei sintomi della Flavescenza dorata,dall'insecchimento delle foglie al
colore bruno che esse assumono, ma non l'appassimento dell' infiorescenza
e del frutto.Vorrei dunque sapere se la diagnosi è corretta e se l'unico rimedio
è l'estirpazione.La ringrazio anticipatamente.
In fede Giuseppe Andolfi.
Il disseccamento delle foglie non è sintomo di FD. Nemmeno il colore bruno.
Le foglie di piante infette da FD si accartocciano vs il basso, assumono
consistenza croccante ed alterano di colore (arrossamento nelle varietà a
bacca nera, ingiallimento in quelle a bacca bianca) sia la lamina che le
nervature. Se inoltre i grappoli si sono sviluppati regolarmente e non sono
disseccati, dubito si tratti di FD.
I tralci sono lignificati normalmente o sono "gommosi"?
Ha notato la presenza della cicalina Scaphoideus titanus?
Attualmente non esiste una cura vera e propria a questa malattia.
E' necessario prevenirla. Importantissimo è effettuare il trattamento contro la cicalina.
Di solito si consiglia di estirpare la pianta quando l'infezione è diffusa a tutti i tralci e
le sue condizioni sono gravi. Se invece i sintomi sono limitati ad uno o pochi tralci,
è possibile che con la potatura si riesca a contenere la malattia (che tra l'altro
ha un andamento molto irregolare durante gli anni).
Comunque, ripeto, indispensabili sono i trattamenti insetticidi contro lo S. titanus!
L'uva americana, comunque, è una varietà che esprime poco i sintomi di questa
malattia, e ne è poco suscettibile.
Flavescenza dorata e sintomi premonitori
Sono un appassionato viticoltore non professionista,approfitto della rubrica
inserita nell'interessante sito della TIGULLIO per cercare di risolvere un
problema che da 2 anni dimezza il raccolto della mia piccola vigna di circa
1000 piante. Premetto che si tratta di un nuovo impianto (5 anni).
Ho impiantato barbatelle di vite americana, successivamente (da tre anni )
innestate con varietà "Sangiovese/pascal/vermentino e qualche altra".
Le piante godono di, una apparente, ottima salute visto che vegetano
abbondantemente e anche la crescita procede come non meglio, visto anche
il terreno molto fertile. Arrivando al sodo, anche quest'anno così come l'anno
passato dopo aver visto comparire tantissimi grappoli su quasi tutte le piante,
mi ritrovo impotente ad assistere ad una "pioggia" di acini in prefioritura con
successivo essicamento prima della estremità e poi di tutto il raspo del grappolo
(prima della caduta gli acini seccano prendendo una colorazione marrone).
Se fosse interessante le faccio presente che ho notato un particolare; la maggior
parte delle piante colpite da questa "malattia, se di malattia si tratta" presentano
una colorazione dei tralci, ormai già lunghi, di un verde intenso (per intenderci,
lo stesso colore che hanno non appena spuntati), e uno sviluppo
sproporzionato di femminelle che poi diventano molto grosse, fino a
raggiungere in molti casi, anche lo spessore del tralcio stesso.
Concludo dicendo che un vecchio viticoltore mi ha detto che dipende dal fatto
che le piante sono giovani e hanno bisogno di qualche anno per fruttificare
normalmente. La cosa mi è sembrata abbastanza strana visto che parecchie piante
mantengono normalmente il frutto.
La ringrazio anticipatamente
Alessandro Meledina Olbia SS
p.s. Così come l'anno passato l'evento si è verificato dopo aver trattato le piante
con sistemici "TOPAS COMBI + RIDOMIL GOLD MZ"
La prima cosa che mi viene in mente in seguito a quello che mi ha descritto, cioè
disseccamento dei grappolini e tralci che non lignificano normalmente, è la Flavescenza
dorata. Tuttavia gli elementi che ho a disposizione, e l'impossibilità di vedere direttamente
le piante, non mi permettono di darle una risposta sicura, la mia è una diagnosi molto
azzardata e suppositiva. Altri elementi tipici di questa malattia, come può leggere nella
scheda relativa pubblicata sul sito, riguardano le foglie, che tendono ad accartocciare
verso il basso e a cambiare di colore (arrossamenti nelle cultivar a bacca nera e
ingiallimenti in quelle a bacca bianca). Inoltre, a luglio-agosto, dovrebbe notare la presenza
della cicalina Scaphoideus titanus, che è il vettore del fitoplasma agente di questa malattia.
Un'ultima cosa: nei vigneti vicini al suo (se ce ne sono) hanno gli stessi problemi? Anche
questo potrebbe essere un indizio indicativo.
Marciume Nero e macchie circolari marroni
Ho una pianta di uva fragola bianca messa a dimora nell'aprile scorso.
E' alta circa mt 1,50 e da qualche tempo presenta le foglie con macchie
circolari di colore marrone chiaro.
Di cosa si tratta ? e quale può essere un intervento efficace ?
La presenza di macchie circolari necrotizzate (disseccate) distribuite
irregolarmente sulla lamina fogliare potrebbe essere dovuta ad un fungo
patogeno responsabile del cosiddetto "marciume nero", o "black rot".
Sugli acini, successivamente, potrebbero comparire dei piccoli punti neri,
accompagnati ad un progressivo raggrinzimento dell'acino stesso.
Non sono del tutto siura che si tratti di black rot, ma dalla descrizione
che mi ha fatto potrebbe esserlo (se può mi alleghi una foto).
Questa malattia può essere combattuta tramite l'utilizzo di fungicidi,
oltre che con l'eliminazione dei tralci infetti che possono costituire una
fonte d'inoculo per ulteriori infezioni.
Spero di esserle stata d'aiuto.
Cordiali saluti.
Melata nera...coccigniglie ?
Mi dedico nel tempo libero alla coltivazione di un piccolo vigneto,
sin da questa estate ho notato sul alcuni ceppi la presenza di una melata
nera. Vorrei conoscerne la causa e il trattamento. Cordiali saluti.
Molto probabilmente si tratta di un'infestazione di cocciniglie.
Questi insetti emettono una sostanza zuccherina, la melata appunto, sulla
quale si nutrono e sviluppano dei funghi nerastri (le fumaggini).
La lotta contro le cocciniglie può essere effettuata chimicamente con un
trattamento di buprofezin in tarda primavera (fine maggio).
Oidio, trattamenti specifici
Salve, vorrei sapere, per quanto riguarda l'oidio, se c'è una cura specifica,
che si può fare in questo periodo.
Solitamente la lotta contro l'oidio si inizia in primavera, in prefioritura,
e prosegue fino alla maturazione del grappolo.
Vengono usati preferibilmente prodotti a base di zolfo, ma può utilizzare anche
altri fungicidi quali Dinocap, Azoxistrobin, triazoli, tetraconazoli, penconazoli,
esaconazoli, pirimidine, strobilurine.
Oidio e Ampelomyces quisqualis
Buongiorno.
Vorrei un suo consiglio. Coltivo un vigneto di Malvasia del Chianti,
Malvasia toscana e Trebbiano Toscano.
Le viti di Malvasia Toscana vengono colpite da Oidio.
Effettuo i seguenti interventi: in fase di ripresa vegetativa e fino alla fioritura
interventi settimanali con zolfo bagnabile, intervallati da uno o due
trattamenti con zolfo in polvere; dalla allegagione all'invaiatura intervengo con
formulati sistemici (Rubigan o altri).
Nonostante i vari interventi, la malattia non scompare ed in alcuni anni
colpisce le viti pesantemente (60/70%).
Ho sentito parlare di un prodotto a base di Ampelomyces quisqualis (AQ10).
Me lo consiglia ? E' efficace? Può indicarmi altri mezzi di lotta?
Grazie di tutto.
Ampelomyces quisqualis è un fungo antagonista che viene spesso consigliato nella
lotta all'oidio, soprattutto in ambito di lotta biologica. Può essere utilizzato in alternativa
ai soliti prodotti a base di zolfo. Viene usato in miscela con olio minerale.
Altri prodotti antioidici utilizzati, oltre ai prodotti a base di zolfo, sono: Azoxistrobin,
Quinoxifen, Tetraconazole, IBS (inibitori della biosintesi degli steroli).
Oidio, sintomi e trattamenti specifici
Sono un neofita nella coltivazione della vite.
Lo scorso anno ho perso tutto il raccolto per una malattia che non sapevo
riconoscere. Quest'anno si sta manifestando lo stesso problema.
Ho chiamato una persona esperta che mi ha detto trattarsi di oidio.
Coltivo principalmente chardonnay a circa 750 m s.l.m.
Questa persona mi ha anche detto che oramai è tardi.
L'attacco è localizzato su un filare. Vorrei sapere se posso fare qualcosa.
Ho effettuato numerosi trattamenti con ossido di rame.
La vegetazione è rigogliosa e l'uva è abbondante. Grazie
L'oidio è una malattia fungina molto diffusa nei vigneti.
E' provocata dal fungo Uncinula necator (forma conidiofora Oidium tuckeri).
Sugli acini compare un sottile strato di muffa polverulenta biancastra.
Per questo motivo è anche chiamato "malbianco".
Gli acini colpiti non si accrescono più in maniera regolare e tendono a spaccarsi,
di conseguenza spesso si ha anche lo sviluppo di muffa grigia (botrite).
La stessa muffa biancastra compare anche sulla superficie fogliare.
Per quanto riguarda la lotta, sono consigliati trattamenti con prodotti a base di zolfo.
Si inizia in primavera, prima della fioritura, e si prosegue fino a tarda estate,
quasi a maturazione.
Oidio e Pinot Grigio
Sono un viticoltore neofita!
Lo scorso anno, nel mio vigneto di Pinot Grigio, in provicncia di Rieti, si è
verificato un forte attacco di Oidio che ha interessato circa il 60% delle viti.
Ho letto che i vigneti colpiti da Oidio sono molto soggetti ad essere
nuovamente colpiti nell'anno successivo.
Quale lotta preventiva mi consiglia di utilizzare e con quali prodotti?
Grazie per la Sua cortese risposta.
Cordiali saluti, Alberto Petroni
La lotta preventiva contro l'oidio, soprattutto in vigneti ove l'infezione si è
verificata negli anni precedenti, quindi in zone ad alto rischio,
viene effettuata precocemente, a partire dalle prime fasi vegetative.
Vengono utilizzati prodotti a base di zolfo, in forma polverulenta o bagnabile,
da somministrare con tempo caldo e secco (l'elevata umidità diminuisce
l'efficacia dello zolfo; temperature molto elevate, oltre i 30°C possono portare
a rischi di fitotossicità).
Sono consigliati poi, alternati allo zolfo, tre trattamenti con IBS
(prodotti Inibitori della Biosintesi degli Steroli); in prefioritura, durante la fioritura
e in postfioritura (allegagione).
Infine, gli stessi prodotti utilizzati contro la peronospora hanno efficacia anche
contro l'oidio.
Peronospora e palline da cimici
Valtellina (Sondrio - 350/400 m s.l.m.)
Ho trovato sotta a una foglia, una forma perfettamente geometrica delle
dimensioni di 0,5 cm x 1 cm, come un rettangolo pero' a punta nel lato
corto superiore formato da palline concatenate (uova ?) delle dimensioni
di 1 mm di color verde e verde chiaro di cui alcunepaiono avere un foro
nella parte centrale e che sono nella quantità di circa 50-60 perfettamente
e, ripeto, geometricamente legate tra loro. Sembrano l'opera di un fine
intarsiatore o uno schema cellulare. Non so se ho reso l'idea, comunque
l'anno scorso sono stato vittima di un potente attacco di peronospora
(mai mi era successo prima (20 anni) che ha peraltro colpito tutta la valle
salvando i piu' fortunati che hanno anticipato i trattamenti, fino ad allora
sempre tenuti alle cadenze dei canonici 14-15 gg.
Ho veramente ragione di preoccuparmi ?
Anche l'anno scorso mi pare di aver già visto tale mosaico geometrico appiccicato
a qualche foglia. Il vigneto puo' risentire dell'attacco di peronospora avuto l'anno
precedente ? Oppure di anno in anno si ricomincia da zero a prescindere dalle
infezioni precedenti ? Cordiali saluti, Corona Nello.
La struttura formata da "palline" che ha trovato attaccata alla pagina inferiore della
foglia è una tipica ovatura costituita dalle uova (tutte perfettamente uguali, deposte
generalmente in gruppi variabili da 60-100 e anche oltre unità) deposte da insetti,
solitamente cimici, poco dannosi alla pianta (al limite creano erosioni alle foglie).
Per quanto riguarda il problema peronospora, le consiglio di effettuare regolarmente
e puntualmente gli interventi consigliati contro questo fungo, a maggior ragione dati
i precedenti attacchi.
Tignoletta e trattamenti con Bacillus
Gentilissima sig.ra Zorloni, sono un appassionato di viticultura, riesco anche
a produrre piccole quantita' di buo vino ad uso esclusivo di amici e familiari.
Non ho mai usato il bacillus thuringensis, lo scorso anno esattamente ad
agosto ho avuto un forte attacco di tignoletta che ha devastato parte del
raccolto, ho gia' installato le trappole a feromoni e ne osservo il volo.
So che è difficile stabilire con esattezza il periodo giusto per i trattamenti
con bacillus, che consiglio mi può dare?
Si può usare bacillus con altri prodotti tipo zolfo, rame, sistemici,
contemporaneamente?
Eventuale liquido restante dal trattamento precedente può essere utilizzato
per quello successivo?
Per quante ore non deve piovere dopo un trattameto affinchè i principi attivi
restino assorbiti o attaccati alla pianta?
La ringrazio di cuore.
G.G.
L'utilizzo di prodotti a base di Bt (Bacillus thuringiensis, var. kurstaki) risulta essere
solitamente efficace nella lotta a Tignola e Tignoletta.
Si tratta di insetticidi selettivi biologici.
Il Bt è un batterio che produce una specifica tossina che agisce contro le larve
dell'insetto per ingestione.
Solitamente questo prodotto è utilizzato in lotta biologica, quindi non associato ad altri
prodotti chimici (non consentiti in tali programmi di lotta). Questo non toglie che, non
operando in ambito di agricoltura strettamente biologica, si possa associare ad altri
prodotti insetticidi.
I prodotti a base di Bt vanno applicati a fine giugno-inizio luglio, all'inizio della schiusura
delle uova della seconda generazione (circa 10 gg dopo l'impennata della curva di volo
dell'insetto, rilevata tramite trappole a feromoni sessuali), e quando si rileva la presenza
dei fori di penetrazione delle larve negli acini.
Il momento più opportuno viene comunque indicato dai Bollettini di produzione integrata
Barbatelle infette ? Virus GLFV
Desidero informazioni riguardanti il virus di vite GLFV (grapevine
fanleaf virus), perchè il mio vigneto di Cabarnet sauvigno a bacca
nera di tre anni (messe a dimora febbraio 2000) composto da barbatelle
innestate, importate da una importante ditta francese, risultano dal
test Elisa effettuato infette dal suddetto virus.
Quindi desidero sapere come comportarmi, le responsabilità, insomma
cosa debbo fare.
Premetto che il terreno era esente da nematodi come da analisi effettuate.
Sarei grato se rispondeste. Grazie
Gentile signor Mistretta,
innanzitutto bisogna vedere che tipo di materiale di propagazione lei ha acquistato.
Infatti, come lei saprà già, il materiale di moltiplicazione viticolo è suddiviso in
tre categorie:
- materiale di base (contrassegnato da etichetta bianca): proveniente da selezione
di cloni iscritti al Catalogo Nazionale delle Varietà.
Questo materiale deve essere sottoposto a saggi che ne verifichino lo stato sanitario,
in particolare l'esenza di virosi quali accartocciamento fogliare, arricciamento fogliare,
legnoriccio, suberosi corticale.
Il materiale di base viene utilizzato per costituire "piante madri" dalle quali viene
prodotto il materiale certificato (tramite talee radicate e non).
- materiale certificato (etichetta azzurra): prodotto a partire da piante madri costituite
con il suddetto materiale di base sottoposto a selezione clonale e controllo sanitario
(tramite rigidi schemi di certificazione). Viene utilizzato per per costituire vivai.
- materiale standard (etichetta arancione): non prodotto tramite selezione clonale, e
non sottoposto a controllo sanitario, quindi di qualità dubbia.
Se ha acquistato materiale certificato, questo deve essere per forza sano.
Potrebbe trattarsi di nuove infezioni, avvenute nel suo vigneto, ma se lei è sicuro
che il terreno è esente da nematodi (vettori del virus dell'arricciamento fogliare), la
cosa mi sembra difficile.
Tutte le piante sono infette?
Credo che farebbe meglio a chiedere spiegazioni a chi le ha venduto le barbatelle,
perchè il materiale certificato deve essere esente da virosi!
Spero di esserle stata un minimo d'aiuto.
Mi informi sugli eventuali sviluppi di questo suo problema.
Eutypa Lata
Nella mia provincia non piove da quasi tre anni e nel 2002 solo una 15 di giorni
accompagnata dalla tramontana (taranto).Notiamo oramai che i ceppi incominciano
a perdere tutte foglie già da luglio per poi seccare l'anno che viene.
Sembra che sia una malattia contagiosa poichè si dice che basterebbero pochi
esemplari in un ettaro che subito il restante viene infetto nel giro di qualche anno.
Personalmente credo che sia la salinità dei terreni,altri parlano di "eutipilata"
(ma cosa è?), altri di acque saline.
Vorrei il suo punto di vista.grazie
In effetti potrebbe trattarsi di "Eutypa lata"; un fungo che determina la malattia
nota con il nome di "eutipiosi".
Il fungo può penetrare all’interno della pianta attraverso ferite, determinate spesso
dai tagli di potatura, ed inoltre può diffondere da pianta a pianta attraverso magari le
stesse forbici da potare.
Colpisce soprattutto le piante vecchie ed indebolite.
La pianta malata assume un aspetto cespuglioso - i germogli hanno sviluppo stentato ed
assai ridotto – i tralci hanno internodi raccorciati – tagliando il tronco, in sezione si
notano delle aree brunastre, necrotiche – le foglie sono clorotiche, piccole,
deformate – colatura dei fiori, disseccamento dei grappolini.
L’intensità dei sintomi peggiora e si aggrava col procedere degli anni, finchè la pianta
non muore (dopo pochi anni, 3-4).
Contro questa malattia è consigliabile prestare attenzione durante la pratica della
potatura ed eliminare (distruggere) i tralci malati, vecchi e secchi.
...spero di esserle stata d'aiuto. Saluti!
Cicalina Bufalo
Buonasera, ho piantato a febbraio 2002 una quarantina di barbatelle
(Merlot, Marzemino, Tocai friulano). Verso la fine di settembre ho notato la presenza
della cicalina bufalo (tra l'altro su un melo piantato anch'esso in primavera).
Ho pensato di avere finalmente scoperto il motivo delle tante foglie diventate rosse
(su merlot e marzemino) visto che tutti i tralci portanti queste foglie avevano il
rigonfiamento o la strozzatura tipica del danno provocato da questa cicalina.
La mia preoccupazione era che potesse essere flavescenza dorata, anche se al
primo anno d'impianto non dovrebbe essere possibile (o sbaglio?).
Come e quando dovrei intervenire per combattere questo insetto?
Ringrazio fin d'ora per la cortesia e saluto cordialmente.
Emilio Santin
Come dice lei non dovrebbe trattarsi di Flavescenza dorata, dal momento che i sintomi
di questa malattia compaiono l'anno successivo l'inoculazione da parte dell'insetto vettore
(e le sue barbatelle hanno solo un anno di vita). I sintomi dovuti alla presenza della
cicalina bufalo, molto simili a quelli causati dalla Flavescenza dorata, sono comunque
assolutamente distinguibili da questi ultimi per la presenza di un cercine anulare sul tralcio.
Ad ogni modo non determinano mai danni rilevanti e non è quasi mai necessario intervenire
con la lotta chimica. Quello che si consiglia di fare, semmai, è di eliminare i tralci che
durante le operazioni di potatura presentano i segni della deposizione delle uova da parte
dell'insetto.
Enazioni...queste sconosciute
Spett.le Anna Zorloni, sono uno studente della facoltà di agraria di Bari.
Vorrei avere maggiori informazioni riguardanti la malattia delle enazioni della vite. Se ci sono
studi fatti a riguardo e quali sono i loro risultati.
La ringrazio in anticipo per la gentile cortesia.
Purtroppo non sono a conoscenza di studi e ricerche fatte in proposito (le consiglierei
di documentarsi presso la biblioteca della sua facoltà). La malattia delle enazioni (enation
disease) è una virosi diffusa nella maggior parte delle aree viticole mondiali, molto diffusa
anche in Italia. Sintomo caratteristico sono le "enazioni", cioè delle proliferazioni lamellari
che si formano sulla pagina inferiore della foglia, solitamente in corrispondenza delle
nervature, in numero e dimensioni variabili.
Nel complesso la pianta non evidenzia sintomi gravi; si può avere un ritardo nel germogliamento
ed una riduzione di produzione.
Molti aspetti di questa malattia, tuttavia, sono ancora poco noti.
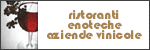








 Torana alla sezione principale
Torana alla sezione principale